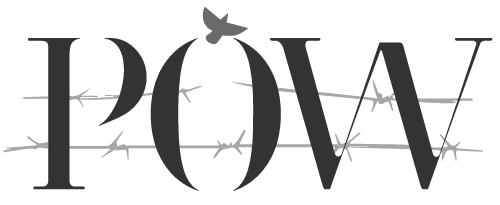©️ IWM (IA 72236)
Gruppo di ex prigionieri
L’annuncio dell’armistizio l’8 di settembre del 1943 ha l’aria di essere la conferma di un qualche cosa che era iniziato con la destituzione di Mussolini il 25 luglio precedente, ovvero la dissoluzione dello Stato italiano. L’Italia fascista, scesa in guerra a fianco delle armate di Hitler per le aspirazioni e gli obiettivi del Duce del fascismo, cessava di esistere come entità autonoma. La dissoluzione dello Stato, cui era seguita la fuga del Re Vittorio Emanuele III e del Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio a Brindisi – nella parte del Paese sottoposta al controllo degli alleati – veniva accompagnata dalla disgregazione delle sue istituzioni, dei suoi corpi, tra le quali le forze armate.
I soldati italiani, molti dei quali ancora di stanza in terre straniere, dalla Jugoslavia alla Grecia venivano così a trovarsi totalmente in assenza di ordini da parte degli alti comandi: aviatori, marinai, truppe di terra erano ora in balia degli avvenimenti e, soprattutto, delle attenzioni per nulla benevole dell’ormai ex alleato tedesco, deciso a vendicare “il tradimento italiano”.
leggi di più
Tuttavia l’armistizio finì per avere delle ripercussioni anche sui prigionieri italiani che affollavano i campi di prigionia delle potenze alleate. Detenuti in campi sparsi per diversi continenti, essi facevano parte – dopo la dichiarazione italiana di guerra alla Germania del 13 ottobre del 1943 – di una nazione divenuta improvvisamente cobelligerante degli alleati. Il nuovo status dell’Italia lasciava sperare ad un ritorno dei prigionieri su suolo nazionale entro tempi brevi ma queste speranze furono presto disattese. Se gli americani effettivamente pensarono ad un possibile rimpatrio, gli inglesi dal canto loro si opposero a questa ipotesi fermamente, sia per ragioni ideali – la Gran Bretagna aveva visto fortemente minacciati i suoi interessi sul Mediterraneo dall’Italia fascista – sia per ragioni economiche legate alla produzione industriale e agricola, per le quali i prigionieri erano ormai fondamentali.
Nelle trattative che precedettero l’armistizio firmato il 3 settembre del 1943 – reso poi pubblico l’8 dello stesso mese – dei prigionieri italiani in mano alleata non si faceva menzione. Gli Stati Uniti in particolare avrebbero ondeggiato tra promesse di un non lontano rientro dei prigionieri e risposte vaghe quando le domande del governo italiano cercavano di andare più nei dettagli. Accanto alle ragioni economiche ve ne sono altre più politiche. Il governo del Sud, in cerca di legittimazione, spingeva per la creazione di unità militari da affiancare agli eserciti alleati nella lotta contro i tedeschi; in questo modo l’Italia avrebbe affrontato la fine della guerra e i processi di pace da una posizione di forza rispetto a quella di un ex nemico e semplice osservatore. L’11 ottobre un messaggio di Pietro Badoglio rivolto proprio ai prigionieri italiani aveva lo scopo di incoraggiarli a cooperare attivamente con gli alleati per una sconfitta delle forze naziste. Tuttavia, anche dopo il “cambio di campo” italiano nessuna delle potenze alleate si sforzò di rilasciare i prigionieri catturati nelle campagne militari nordafricane, mentre ciò avvenne ad esempio per i soldati italiani catturati in Sicilia nel luglio del 1943. Continuare con la detenzione dei prigionieri italiani poneva però alle potenze alleate un problema di natura giuridica. La Convenzione di Ginevra del 1929 stabiliva nell’articolo 75 che in seguito all’atto di firma di un armistizio tra due paesi belligeranti, si stabilissero accordi per garantire il rimpatrio dei prigionieri in tempi rapidi. Gli alleati opposero le motivazioni più varie alla liberazione dei prigionieri italiani – alcune oggettive altre pretestuose – e in definitiva si tennero ben stretti le decine di migliaia di prigionieri che avevano in custodia. Le scuse addotte spaziavano dalla difficoltà dei trasporti via mare alla presenza di numerosi fascisti convinti all’interno dei campi e dunque di individui pericolosi per le logiche di guerra alleate. I motivi erano in realtà legati a esigenze più concrete: la manodopera italiana era estremamente importante per lo sforzo bellico alleato, per le industrie e per le lavorazioni connesse all’agricoltura. Basti pensare che gli ultimi militari italiani detenuti in Gran Bretagna tornano al principio dell’autunno del 1946, solo dopo la conclusione della raccolta di patate e barbabietole da zucchero. In ogni caso dopo gli avvenimenti del settembre 1943, gli alleati optano per la divisione dei prigionieri secondo una semplice classificazione: “cooperatori” e “non cooperatori”. Diventare cooperatori significava di fatto però partecipare attivamente agli sforzi bellici degli alleati, ed anche ciò era contrario alle regole stabilite dalla Convenzione di Ginevra. Per superare questo ulteriore scoglio gli alleati attuarono una strategia: far mettere per iscritto ai prigionieri detenuti nei vari campi che «volontariamente accettavano di compiere qualsiasi lavoro, anche se proibiti dalla Convenzione di Ginevra, pur continuando a restare prigionieri» (Conti, Bologna 1986, p.167). Questa situazione provocò grandi lacerazioni all’interno dei campi, dove i prigionieri italiani cominciarono a dividersi: la guerra civile che stava dilaniando l’Italia sembrava ripresentarsi dietro il filo spinato della prigionia. Chi decideva di non cooperare con gli alleati poteva avere diverse ragioni per la sua scelta: sincere convinzioni fasciste, fedeltà alla monarchia sotto la quale era andato in guerra o semplicemente la paura di generare ritorsioni sulla famiglia che aveva lasciato in patria. Sia che fossero cooperatori o meno, i militari italiani conservarono lo status di prigionieri anche dopo la cessazione delle ostilità nel 1945, ed anzi, fu allora che le condizioni materiali, legate ad esempio al vitto, addirittura peggiorarono. Le operazioni di rimpatrio furono lente e macchinose e ciò non esclusivamente per ragioni da imputare alle nazioni alleate, ma anche a causa del disinteresse e della disorganizzazione del Governo italiano. In un paese economicamente provato e segnato dalle distruzioni della guerra, una massa di prigionieri improvvisamente calata sul suolo nazionale poteva rappresentare un problema; inoltre idealmente questi soldati rappresentavano un’altra Italia, sconfitta, quella fascista entrata in guerra al fianco delle truppe tedesche. A gruppi e, con tempistiche diverse, i prigionieri italiani cominciarono lo stesso ad essere rimpatriati con i loro traumi anche se non furono pochi i casi di ex prigionieri che preferirono rimanere nel paese di prigionia, creando talvolta una famiglia con donne del luogo. Per chi invece si apprestava a tornare, il viaggio avveniva in gran parte – a seconda delle provenienza – in nave, su rotaia, oppure in ambedue i modi; dalla Gran Bretagna ad esempio si giungeva via nave a Calais e poi di lì a Verona, viaggiando su treno. Il rimpatrio dei prigionieri italiani cominciò a partire dall’autunno-inverno del 1945, eppure per diversi individui i tempi si allungarono e di molto: gli ultimi militari tornarono a casa solo nel 1947.
Testo a cura di Luca Zanotta
FONTI
Fonti d’archivio
–
Bibliografia
F. Conti, I prigionieri di guerra italiani: 1940-1945, Bologna, Il Mulino, 1986
I. Insolvibile, Wops. I prigionieri di guerra italiani in Gran Bretagna (1941-1946), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012
Sitografia
N. Conti, Il 25 aprile non arrivò per tutti: il ritardato rimpatrio dei prigionieri di guerra italiani in Gran Bretagna (1945-1946), pubblicato sul portale www.isrecbg.it consultato il 24/06/2024
Articoli correlati
- I CAMPI DEGLI ALLEATI
- IL TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI NEI DIVERSI CAMPI
- IL RUOLO DELLA CROCE ROSSA INTERNAZIONALE
- COSA ACCADEVA AI PRIGIONIERI UNA VOLTA RIENTRATI IN PATRIA?
- LE INIZIATIVE PUBBLICHE FINALIZZATE AD ASSISTERE I RIMPATRIATI E A FAVORIRNE IL REINSERIMENTO NELLA SOCIETÀ NELL’IMMEDIATO DOPOGUERRA